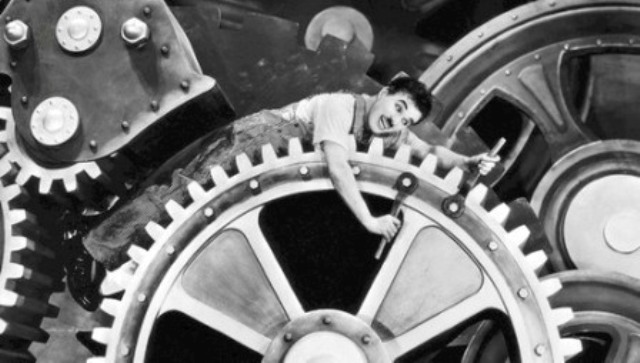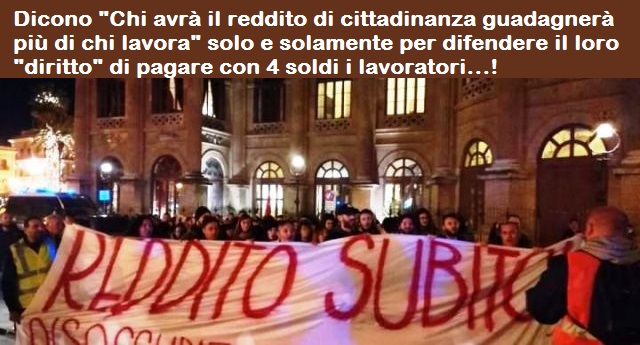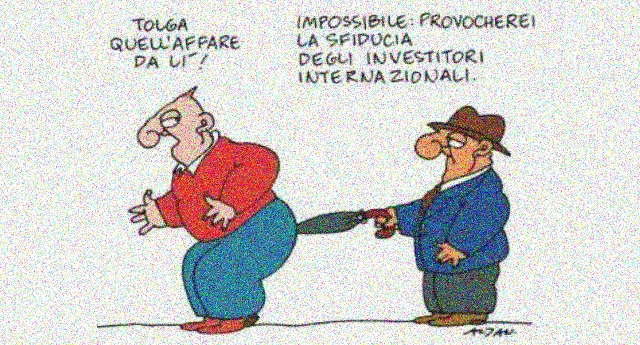.
.
SEGUICI SULLA PAGINA FACEBOOK Banda Bassotti
.
.
La crisi? Non per tutti: in tre anni per le industrie i profitti sono cresciuti del 40%… I salari solo del 5%
La ricchezza, quando c’è cresce, ma ai lavoratori arrivano solo le briciole. Il Sole 24 Ore riferisce i risultati di una ricerca effettuata dalla Fondazione Sabattini, che ha analizzato il rapporto tra gli utili delle aziende e i salari operai nelle aree industriali di Milano, Reggio Emilia e Veneto (il “triangolo” che tira, ndr) e pensa di estendere la ricerca anche al resto del paese.
La ricerca ha analizzato l’andamento dei salari e degli utili nelle imprese metalmeccaniche del Veneto con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 esaminando i bilanci aziendali di imprese “attive”, iscritte alle Camere di commercio venete, di tutte le forme giuridiche possibili. L’andamento delle principali variabili è stato analizzato dal punto di vista del loro andamento nel tempo e del loro rapporto con il valore aggiunto.
In particolare è stato preso in considerazione il periodo che va dal 2015 al 2018, un arco temporale scelto non casualmente in quanto è stato possibile osservare i cambiamenti che si sono registrati a cavallo del contratto nazionale dei metalmeccanici del 2016, l’anno precedente al contratto e i tre anni successivi, per capire se le imprese venete avessero generato ricchezza e dove fosse andata.
I settori convolti sono quelli delle attività metallurgiche, la fabbricazione di prodotti in metalli (esclusi macchinari e attrezzature), la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, la fabbricazione di apparecchiature elettriche, la fabbricazione di macchinari e apparecchiature Nca (non codificato altrove, ndr), la fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, la fabbricazione di altri mezzi di trasporto, la riparazione e installazione di macchine e apparecchiature.
Dalla ricerca emerge che le imprese venete sono state in grado di generare ricchezza e che dal 2010 al 2018 gli utili sono cresciuti del 100% mentre i salari sono cresciuti solo del 37%.
Se poi si guarda al periodo 2015/18, la crescita degli utili è stata di quasi il 40%, mentre quella dei salari è stata di poco più del 5%, di conseguenza è cambiata l’incidenza sia degli utili che dei salari sul valore aggiunto, cioè sulla ricchezza generata dalle aziende.
L’indagine mostra anche come questa ricchezza non si stata neppure utilizzata per investimenti, ma sia stata prevalentemente assorbita dagli utili.
tratto da: http://contropiano.org/regionali/veneto-nordest/2019/12/29/nelle-industrie-in-veneto-profitti-cresciuti-del-40-salari-del-5-0122396?fbclid=IwAR0wGdFJ19mu9gUVUpWu2I7riYExEFwwOCUr-dgtdsG6CJNo_vs003ZLpEo